archeoviewer
Sistema per la realizzazione di archivi informatizzati e
di supporto tecnico per la gestione del territorio, totalmente digitale
ed integrato con tutti gli aspetti scientifici, tecnici ed
amministrativi.
Archeoviewer è un sistema per la condivisione dei dati scientifici sia
su supporti locali (PC, server, LAN) sia sul web
et alter ... et
alter 2 ...
.gif)

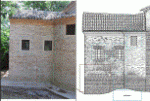
demo 1 demo
2 demo 3
archeoVIEWER
ISTRUZIONI PER L'USO
PER VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI QUESTE PAGINE OCCORRE AVER INSTALLATO ACROBAT READER per gli utenti Mac ......
i link sopra aprono file pdf che sono un'applicazione di archeoviewer "classica", con
i campi colorati che richiamano altre viste
del documento o visualizzano immagini fotografiche del progetto
realizzato.
attivando lo strumento "mano" di Acrobat ci si può spostare sulla
pagina e lanciare i lnk attivi, tenendo premuto
il tasto Ctrl ed usando la rotella si può fare zoom avanti ed
indietro.
il sistema dovrebbe essere configurato in modo da aprire il pdf
direttamente dal browser
ATTENZIONE NORMALMENTE ACROBAT READER HA UNA PROTEZIONE CHE AVVISA
QUANDO SI APRONO I LINK ALLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE CHIEDENDO SE "IL SITO
E' AFFIDABILE..." FIDATEVI
AVVISO PER GLI UTENTI MAC
IL SISTEMA OPERATIVO MAC HA GENERALMENTE INSTALLATO UN
VISUALIZZATORE DI PDF NATIVO CHE NON E' COMPATIBILE CON LE
FUNZIONALITA' DI QUESTI FILE. SCARICATE LA VERSIONE GRATUITA DI
ACROBAT READER DAL SITO DI ADOBE.COM
Un po' di storia del progetto
archeoVIEWER
Siamo partiti dalla realizzazione di una Carta Archeologica
Informatizzata.
I concetti esposti su questa pagina propongono, tuttavia, un metodo di
lavoro che travalica dal “semplice” ambito della realizzazione di una
carta archeologica e che può essere applicato a diversi contesti quali,
ad esempio, l’informatizzazione della cartografia vincolistica (non
necessariamente archeologica) e/o di un centro storico, la
documentazione di un intervento di restauro, macro e micro ambiti
caratterizzati da un contesto territoriale, da testi scientifici ed
amministrativi, da documentazione grafica e fotografica. Sarebbe troppo
lungo procedere ad una disamina delle potenzialità offerte dalle
procedure che stiamo per discutere, quindi si rimandano ad altra sede i
dettagli.
Definizioni.
Di seguito verranno utilizzati alcuni termini di cui vorremmo chiarire
il significato attribuito nell’ambito del presente lavoro, anche se
meglio specificati in alcune parti del testo.
Documentazione grafica: qualsiasi elaborato destinato a definire la
morfologia e le caratteristiche strutturali di un’evidenza archeologica
(o storico-artistica).
Testo: qualsiasi elaborato prodotto con riferimento ad una struttura
archeologica (idem) per le sue esigenze di documentazione,
catalogazione, tutela, amministrazione e gestione rispetto al suo
contesto.
Formato digitale originale: file prodotti da singoli programmi
proprietari del copyright che, normalmente, possono essere aperti per
l’editing solo da tali programmi. Talvolta i file possono essere
visualizzati e/o stampati da programmi “paralleli” (viewer) che non
svolgono funzioni di modifica.
Collegamento ipertestuale (link): “testo o elemento di grafica a colori
e sottolineato su cui è possibile fare clic per passare a un file, a una
posizione all'interno di un file, a una pagina HTML sul Web o a una
pagina HTML su una Intranet. I collegamenti ipertestuali possono inoltre
essere associati a newsgroup e a siti Gopher, Telnet e FTP” (dalla guida
di Windows). In pratica consiste nella possibilità di aprire, a partire
da un dato file, un altro qualsiasi file mediante il programma che
gestisce quest’ultimo.
I presupposti da cui si è partiti sono i seguenti.
L’esperienza maturata finora (nella realizzazione di carte archeologiche
e cartografia tematica, di seguito Carta) ha delineato nettamente i
limiti di simili operazioni che, essenzialmente, sono prodotte mediante
l’uso di programmi applicativi CAD o GIS e, pertanto, di uso esclusivo
del personale “tecnico”, sia esterno che compreso nella struttura della
soprintendenza che ha commissionato il lavoro. Gli elaborati finali,
anche se consegnati in allegato nel formato digitale originale, sono
consultabili e modificabili solo da coloro che hanno una discreta
pratica di tali applicativi e, soprattutto, possono lavorare su macchine
fornite delle licenze dei relativi programmi. Tutti gli altri potenziali
utilizzatori (funzionari, personale amministrativo e utenti a vario
titolo) devono accontentarsi degli elaborati grafici in forma cartacea o
sotto forma di immagini in formato .JPG, .TIF, ecc. oppure, al massimo,
dei programmi “paralleli” di cui sopra. Tale assunto non inficia
l’efficacia della redazione di una Carta su base informatizzata (nel
senso che il prodotto esiste ed è fruibile dalla committenza, anche se
in modo limitato) ma, di fatto, rimane privo di due requisiti a mio
avviso fondamentali:
* la possibilità di interagire con altre informazioni digitali
correlate, anche in forma non grafica (testi, fotografie) e,
soprattutto,
* la possibilità di conservazione ed aggiornamento nel prosieguo
dell’attività scientifica nella stessa area, da parte degli stessi
utilizzatori, senza dover ricorrere ai professionisti che l’hanno
realizzata.
torna su
Chiariamo alcuni concetti.
Per quanto riguarda la “possibilità di interagire con altre
informazioni” si intende la possibilità che la Carta, oltre ai consueti
dati planimetrici sulle evidenze presenti nell’area, contenga anche
ulteriori dati, sia di carattere esclusivamente grafico (altri elaborati
riguardanti gli alzati, dettagli a scala maggiore, ecc.), sia
fotografico (foto di archivio o recenti, immagini satellitari, ecc.),
sia di carattere amministrativo e di tutela (decreti di vincolo, atti
demaniali sulle competenze, perizie per interventi, relazioni di scavo,
ecc.), sia, infine, di carattere scientifico (articoli e pubblicazioni,
pagine web, ecc.). Si badi bene: “contenga anche ulteriori dati” non
significa necessariamente che questi ultimi siano effettivamente
presenti nei file che effettivamente compongono la Carta, ma solo che
gli stessi possano essere riferiti al contesto della stessa.
Detto in parole povere, si tratta della possibilità di associare
(secondo criteri molteplici e definibili in fase di progettazione) e
rendere interattivi tra loro tutti i tipi di documentazione che, pur
gestiti da programmi diversi e provenienti da fonti eterogenee (memorie
su disco, server di rete, web), siano normalmente visualizzabili e
consultabili sul monitor di un computer o, mediante semplici operazioni
di archiviazione digitale, attualmente disponibili solo in forma
cartacea.
In poche parole, si tratta della possibilità di avere tutta una serie di
collegamenti ipertestuali tra i dati grafici presenti sulla Carta ed
“altri” dati.
Per quanto riguarda “la possibilità di conservazione ed aggiornamento”
della Carta si intende quello che forse è il nodo cruciale del presente
lavoro: dare la possibilità, a coloro che il progetto individuerà come
gestori delle informazioni raccolte in forma digitale, di integrare le
stesse in futuro (una volta realizzata la Carta) con l’ulteriore
materiale che, inevitabilmente, si produce lavorando in un dato ambito
territoriale.
Quanto detto finora potrà sembrare ai più estremamente banale: tali
funzionalità, infatti, sono una delle prerogative della tipologia di
applicativi noti come GIS (Geographical Information System) ed operanti
da anni. Vediamole nel dettaglio, a partire dalle definizioni.
Secondo la definizione di Burrough (1986) "il GIS è composto da una
serie di strumenti software per acquisire, memorizzare, estrarre,
trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale". Si tratta di
un sistema informatico in grado di produrre, gestire e analizzare dati
spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni
alfanumeriche. Il GIS è differente dal DBMS (o Database Management
System), in quanto si occupa essenzialmente dell'elaborazione e
manipolazione dei dati georeferenziati, che a loro volta possono essere
memorizzati in un DBMS o in singoli file. SIT è l'acronimo italiano di
Sistema Informativo Territoriale, e coincide con la traduzione inglese
Geographical Information System. Mogorovich (1988) ha definito il
sistema informativo territoriale "Il complesso di uomini, strumenti e
procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la
distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono
disponibili nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità
per svolgere una qualsivoglia attività".
Modello dei dati
Per la rappresentazione dei dati in un sistema informatico occorre
formalizzare un modello rappresentativo flessibile che si adatti ai
fenomeni reali. Nel GIS abbiamo tre tipologie di informazioni:
Geometriche: relative alla rappresentazione cartografica degli oggetti
rappresentati; quali la forma (punto, linea, poligono), la dimensione e
la posizione geografica;
Topologiche: riferite alle relazioni reciproche tra gli oggetti
(connessione, adiacenza, inclusione ecc…);
Informative: riguardanti i dati (numerici, testuali ecc…) associati ad
ogni oggetto.
Il GIS prevede la gestione di queste informazioni in un database
relazionale. L'aspetto che caratterizza il GIS è quello geometrico: esso
memorizza la posizione del dato impiegando un sistema di proiezione
reale che definisce la posizione geografica dell'oggetto. Il GIS
gestisce contemporaneamente i dati provenienti da diversi sistemi di
proiezione e riferimento (es. UTM o Gauss Boaga) A differenza della
cartografia su carta, la scala in un GIS è un parametro di qualità del
dato e non di visualizzazione. Il valore della scala esprime le cifre
significative che devono essere considerate valide delle coordinate di
georiferimento.
(da wikipedia, voce Sistema Informativo Geografico, versione italiana,
consultabile all’indirizzo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informativo_geografico
)
Riprendendo le piccole note polemiche di poco sopra, se c’è già il GIS
che fa tutte queste cose, dove sta il problema? Ebbene, il problema è
proprio che queste cose le fa solo il GIS, ovvero un tipo di programma
specifico, spesso complicato ad usarsi, quasi sempre molto costoso
(anche se esistono diverse versioni freeware ed open source, vedi
http://www.gfoss.it/drupal/ ), escludendo, di fatto, una grossa fetta di
potenziali utenti.
L’esigenza che sta alla base del progetto descritto su queste pagine,
invece, è proprio quella ai allargare il più possibile la base degli
utenti, semplificando al massimo gli strumenti di accesso e la
leggibilità delle informazioni associate ai dati cartografici.
torna su
Strategia del progetto.
Seguendo la logica esposta finora, un aspetto fondamentale è costituito
dalla scelta dell’ambiente in cui operare.
Ferma restando la necessità di elaborare ed assemblare le informazioni
di carattere grafico (cartografico e di documentazione grafica) in
ambienti di tipo CAD o GIS in un ambito operativo piuttosto ristretto,
la fruibilità del prodotto finale sarà resa possibile impostando una
serie di specifiche volte alla massima flessibilità d’uso per gli utenti
finali, impiegando mezzi semplici ed alla portata di tutti. Dando per
scontato che, ormai, una gran parte dei programmi rende possibile
l’inserimento di collegamenti ipertestuali (ovvero, offre la possibilità
di collegare ad un file un qualsiasi altro documento, anche di tipo
diverso, e di lanciare l’applicativo che lo gestisce) rimane da
scegliere il tipo di ambiente più idoneo.
Da una parte abbiamo la sofisticata famiglia di prodotti GIS e gli
applicativi in ambiente CAD specifici per la cartografia (di cui alcuni,
specialmente i primi, disponibili con licenza freeware), particolarmente
efficienti per le applicazioni del cui ambito stiamo discutendo, ma
irrimediabilmente legati al programma proprietario del formato. Tali
prodotti, pur essendo praticamente nati per tali usi, richiedono una
preparazione specifica per il loro uso e, di fatto, scoraggerebbero
molti potenziali utenti oltre a richiedere (quelli “commerciali”)
costose licenze d’uso.
Dall’altra abbiamo la possibilità di produrre (a partire dai suddetti
applicativi in formato vettoriale in ambiente CAD) elaborati digitali
che possono essere aperti e gestiti da programmi comunemente diffusi,
eventualmente scaricabili gratuitamente da Internet. Tali applicativi,
oltre alla semplicità d’uso ed al costo irrisorio (perché spesso
compresi nei pacchetti forniti con i sistemi operativi) hanno anche il
pregio di gestire file di dimensioni estremamente ridotte, con un
notevole risparmio di risorse hardware. Ovviamente, visto che parliamo
della necessità di far vedere su monitor dei dati cartografici
(vettoriali o raster), dobbiamo partire dalla possibilità di trasformare
questi in immagini.
Per dare alcuni riferimenti, i due formati più diffusi per la
visualizzazione delle immagini (nel nostro caso, cartografiche) sono
quelli .PDF (gestito dalla famiglia di prodotti Adobe) e quelli .JPG
che, per quanto attiene alla gestione dei riferimenti ipertestuali,
possono essere aperti dalla nutrita schiera dei browser di Internet. I
primi, inoltre, hanno la possibilità di consentire la stampa parziale
degli elaborati (ovvero, consentono la scelta di “finestre” di stampa
minori della “pagina” nel cui formato sono stati elaborati) e, per
entrambi, esiste la possibilità di estrarne delle porzioni con le
funzioni di “copia e incolla” dei normali editor (anche questi gratuiti
sulla rete) per stamparli per parti con una accettabile perdita di
risoluzione.
I primi (.PDF) consentono, in compenso, una visualizzazione a video
estremamente dettagliata a fronte di una estrema compressione della
dimensione dei file in confronto a quelli originali e, soprattutto, alle
immagini in .JPG.
In entrambi i casi la procedura per la produzione degli elaborati finali
dovrebbe prevedere:
* un elaborato intermedio “grezzo” dal programma GIS o CAD usato per
l’elaborazione della cartografia (praticamente il master di tutto il
lavoro), reso come stampa virtuale in formato .PDF o . JPG;
* un’elaborazione da parte di un programma proprietario del file in
formato .PDF o .JPG (nel primo caso Adobe Acrobat, nel secondo uno tra i
tanti gestori di pagine html) per l’inserimento dei collegamenti
ipertestuali.
torna su
Il progetto di informatizzazione di un’area archeologica.
Il primo problema di un’area in cui, nel tempo, sono stati spesso
condotti diversi interventi di scavo, studio, restauro, tutela e
documentazione, sta spesso nella frammentarietà dei dati e,
particolarmente, nella loro quasi esclusiva esistenza in forma cartacea.
Rimanendo per ora nel solo ambito della documentazione grafica dei siti
archeologici “storici”, ci troviamo spesso in presenza di tutta una
serie di disegni, redatti in epoche e con modalità diverse, relativi a
porzioni (più o meno estese) del territorio, talvolta sprovvisti di
riferimenti cartografici certi, quasi sempre privi di collegamenti
reciproci. Anche volendo ignorare le difficoltà di natura logistica che
i funzionari incontrano nel gestire una tale massa eterogenea di
documenti, uno dei noccioli del problema sta nella effettiva
potenzialità di tutelare il patrimonio e nella possibilità di interagire
con le varie entità amministrative che ad esso afferiscono.
Si tratta, in sostanza, della possibilità di gestire in modo snello e
funzionale una notevole quantità di informazioni, rendendole omogenee e
riferite (o meglio, georiferite) al contesto territoriale cui fanno
riferimento.
Il progetto della Carta Archeologica Informatizzata può essere
schematizzato nei seguenti obiettivi.
1. Acquisizione di una base cartografica digitale (possibilmente
georeferenziata), presso le amministrazioni locali, anche al fine di
possedere una base comune “di dialogo” con le stesse per quanto attiene
agli atti amministrativi di tutela del territorio.
2. Ricognizione presso l’archivio della Soprintendenza (e di tutte le
istituzioni che hanno condotto interventi di scavo o di studio
nell’area) per reperire tutti gli elaborati che sono stati prodotti nel
corso del tempo e procedere ad una selezione secondo criteri di priorità
ed affidabilità.
3. Realizzazione di una base topografica georeferenziata per la
collocazione esatta delle evidenze archeologiche e, soprattutto, per
collegare in modo funzionale sia i vari frammenti di documentazione
esistente sia quella prodotta in epoca recente con criteri moderni, al
fine di stabilire un protocollo univoco per la documentazione futura ed
il suo inserimento nel contesto.
4. Digitalizzazione degli elaborati di archivio ed inserimento negli
stessi nella base cartografica generale, prevedendo la possibilità di
collegamenti ipertestuali e, soprattutto, di aggiornamento dinamico
della Carta secondo criteri univoci di riferimento, .
5. Produzione degli elaborati per la consultazione della Carta a diversi
livelli e secondo aree tematiche stabilite, con la possibilità di
gestire le aggregazioni dei dati in modi diversi.
Una volta costruita questa struttura (in ambiente CAD o GIS) sarà
possibile pensare all’inserimento di qualsiasi altro tipo di dato
correlato alla singola evidenza archeologica, da gestire come
riferimento ipertestuale.
Si potrà quindi associare al singolo monumento (e consultare in modo
dinamico) foto, schede o testi, documentazione grafica di dettaglio
(anche raster di disegni cartacei di archivio), bibliografia, documenti
amministrativi e quant’altro si dovrà produrre sullo stesso in futuro,
collegando tali dati provenienti da qualsiasi fonte: supporti magnetici
ed ottici locali, server della Soprintendenza o del Ministero, rete
Internet.
Nell’elenco che abbiamo appena esposto i punti da 1 a 4 devono essere
necessariamente eseguiti in ambiente CAD e, quindi, per quanto detto
sopra rimangono di fatto una prerogativa di un’elite “tecnica” (interna
o esterna alla soprintendenza che ha commissionato il lavoro) in
possesso sia delle conoscenze per usare tali programmi sia delle
relative licenze d’uso. Fin qui niente di nuovo, nel senso che tale
procedura è quella normalmente usata per la produzione degli elaborati
“classici”, ovvero stampe su carta, file vettoriali consegnati per
l’archiviazione e, tuttalpiù, immagini in vario formato raster per poter
essere consultate senza usare i programmi proprietari .
Questo tipo di materiale, ferma restando la validità e la qualità del
lavoro svolto, ha un solo difetto: non consente la possibilità di essere
collegato ad altri dati di qualsiasi tipo (che, pure, esistono o possono
essere prodotti in futuro), compresi quelli grafici; in una parola, si
tratta di materiale statico. Tanto per rimanere nell’ambito della
documentazione grafica, probabilmente le strutture inserite nella
planimetria georeferenziata in formato vettoriale (quindi con il solo
perimetro delle murature sezionate e dei principali elementi proiettati
resi con una grafica compatibile con una scala di 1:500-1:200) avranno
sicuramente dei dettagli con una caratterizzazione a scala maggiore (ad
esempio 1:50) e, probabilmente, delle sezioni e dei prospetti. Sia che
tali elaborati siano stati prodotti in formato vettoriale, sia in
versione “tradizionale” (disegni su lucido o poliestere, eventualmente
digitalizzati mediante scanner), la loro consultazione deve
necessariamente avvenire separatamente da quella della Carta, senza
possibilità di collegamenti dinamici.
Al pari dei dati grafici, se per i siti compresi nella nostra Carta
esistono altri tipi di documentazione (a puro titolo di esempio: foto,
relazioni di scavo, schede US, disegni di materiali, decreti di vincolo,
materiale di archivio, ecc.), magari già in formato digitale, finora non
è stato possibile renderlo evidente (e disponibile) nel contesto che
abbiamo sopra descritto.
torna su
Il progetto ArcheoViewer.
Dopo questa (purtroppo) lunga premessa, arriviamo al nocciolo della
questione. Quella che si sta per proporre è fondamentalmente un’idea,
tanto semplice quanto rivoluzionaria, tuttora in corso di sviluppo, per
semplificare la realizzazione di cartografia (e non solo) di tipo GIS e,
soprattutto, per allargare al massimo la base di coloro in grado di
consultare tali elaborati. Non si tratta di un nuovo programma ma,
piuttosto, di una procedura (tendenzialmente, di un protocollo per la
codifica di una serie di azioni) per la produzione, l’editing e la
gestione di immagini e dati.
Parallelamente, questo progetto costituisce un sistema per la
realizzazione di archivi informatizzati e di supporto tecnico per la
gestione del territorio, totalmente digitale ed integrato con tutti gli
aspetti scientifici, tecnici ed amministrativi. Per rendere l’idea in
poche parole, un sistema con (quasi) le stesse funzionalità di un GIS,
molto più semplice, versatile, economico (sia dal punto di vista venale
che delle risorse hardware) ed aperto all’utenza finale, che chiunque
sappia avviare un computer può essere in grado di usare.
torna su
per saperne di più:
scrivimi
vedi demo 1
vedi
demo 2
vedi demo 3
segui su questo sito l'evoluzione del progetto
torna alla home page